Foto di Michelle Celedon su Unsplash
Una scia di dolore e rabbia
L’Italia in questi giorni è stata sconvolta da due nuovi casi di femminicidio: Sara Campanella e Ilaria Sula, due giovani studentesse universitarie che sono state uccise da uomini che non accettavano un rifiuto, la fine di una relazione, il diritto alla libertà. La notizia ha generato un’ondata di dolore, ma anche di rabbia, sfociata in cortei, fiaccolate e manifestazioni in tutta la penisola. Ancora una volta, la società civile si è trovata a chiedere giustizia non solo per le vittime, ma per tutte le donne che vivono in una realtà dove la violenza di genere persiste ancora.
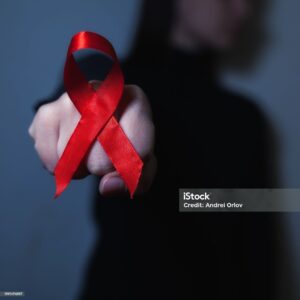
Le storie di Sara e Ilaria
Sara Campanella aveva 22 anni ed era studentessa di Biomedicina all’Università di Messina. È stata uccisa il 31 marzo dal suo compagno di studi, Stefano Argentino, che la perseguitava da tempo. Argentino l’ha colpita alla schiena e al collo cinque volte con un taglierino nei pressi della fermata dell’autobus. Sara aveva più volte manifestato il suo disagio e lo stalking da parte dell’uomo, ma le sue richieste d’aiuto non sono bastate a proteggerla.
Ilaria Sula, anche lei 22enne, studiava Statistica alla Sapienza di Roma. Il suo corpo senza vita è stato trovato in un dirupo chiuso in una valigia il 2 aprile. Reo confesso dell’efferato delitto l’ex fidanzato, Mark Samson, aiutato nell’occultamento del cadavere dalla madre. Ilaria aveva interrotto la relazione da mesi e si era recata a casa dell’ex per restituirgli oggetti personali, ma da quella casa non è mai uscita viva. Anche nel suo caso, ci sono segnali di precedenti comportamenti ossessivi e aggressivi.
Due storie diverse, ma unite dalla stessa tragica conclusione: la violenza maschile che si abbatte su donne giovani, indipendenti, che avevano scelto di vivere libere.

Le manifestazioni: una rivolta collettiva
Le piazze italiane si sono trasformate in luoghi di memoria e denuncia. A Roma, il presidio di fronte all’Università La Sapienza ha visto la partecipazione di migliaia di studenti, docenti e cittadini comuni. I partecipanti hanno portato fiori, cartelli, striscioni: “Per Sara, per Ilaria, per tutte”, “Non è follia, è patriarcato”, “Libere di scegliere, libere di vivere”. Il corteo ha attraversato le vie del quartiere San Lorenzo in silenzio, interrotto solo dalla lettura di testi scritti da donne sopravvissute alla violenza.
A Bologna, piazza Maggiore è diventata un grande abbraccio collettivo: circa 2.000 persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata da “Non Una Di Meno”. In silenzio, con candele accese e fazzoletti viola, hanno ricordato Sara e Ilaria ma anche tutte le altre vittime. Alcune donne hanno preso il microfono per raccontare esperienze personali, rompendo il silenzio che spesso accompagna la violenza domestica e relazionale.
A Messina, dove studiava Sara, l’università ha sospeso tutte le attività per un giorno. Studenti e professori si sono ritrovati nel cortile centrale per un minuto di silenzio, seguito da un’assemblea pubblica. Il rettore ha parlato di “una ferita profonda per l’intera comunità”, mentre molte ragazze hanno chiesto interventi concreti contro la cultura del possesso e della sopraffazione.
Anche in città più piccole – da Trento a Lecce, da Pisa a Reggio Calabria – si sono tenute iniziative spontanee. Giovani, collettivi femministi, centri antiviolenza, ma anche famiglie, scuole, associazioni. Il messaggio era uno solo: “Non è un caso isolato. È un sistema che uccide”.
Commenti che svelano una cultura malata
Mentre le strade si riempivano di solidarietà, i social e i media si popolavano di commenti inaccettabili, che cercavano – più o meno esplicitamente – di incolpare le vittime. Frasi come “Prima o poi qualcuno perde il controllo, sono eroi per noi”, “Perché era ancora in contatto con lui?”, “Se l’è cercato!”, “La vittima è lui!” “Il femminicidio non esiste!” sono emerse con sconcertante frequenza. Questi giudizi mostrano quanto sia ancora radicata la tendenza a colpevolizzare le donne per la violenza che subiscono. È un riflesso diretto della cultura patriarcale, quella che insegna che la donna debba proteggersi, moderarsi, non “provocare”, mentre all’uomo viene spesso concessa la “giustificazione” del rifiuto o del dolore.
Il patriarcato non è un fantasma del passato
Questi episodi dimostrano che il patriarcato, lungi dall’essere superato, è ancora profondamente vivo. Non si tratta solo di relazioni violente, ma di una struttura sociale che normalizza il possesso, giustifica l’aggressione, riduce la libertà delle donne. Le manifestazioni non sono solo una reazione emotiva: sono un atto politico, una sfida aperta a un sistema che continua a fallire nella prevenzione, nell’educazione e nella protezione.
Verso un cambiamento possibile
L’Italia è tra i pochissimi paesi europei a non avere programmi di educazione sessuale e affettiva obbligatoria nelle scuole. Nonostante la proposta di legge di iniziativa popolare dello scorso febbraio, il governo non ha ancora introdotto alcuna regolamentazione, ignorando i report di OMs e Unesco.
Le piazze non chiedono vendetta. Chiedono ascolto, educazione emotiva e sentimentale, politiche reali. Chiedono che la violenza venga riconosciuta e affrontata fin dalle sue radici culturali, nelle scuole, nei media, nella giustizia. Chiedono che la parola “femminicidio” non sia più seguita da un altro nome, un altro volto, un’altra storia. Perché ogni volta che una donna viene uccisa, non muore solo una persona, ma viene tradita un’intera società.
È inaccettabile che, nel 2025, le donne debbano ancora lottare per il diritto a vivere senza paura. Le piazze parlano chiaro: non è più il tempo del silenzio, ma dell’azione.
“Non vogliamo più contare i nomi, vogliamo scrivere futuro.”
Di Giorgia Martora
Classe 5D Liceo Scientifico
